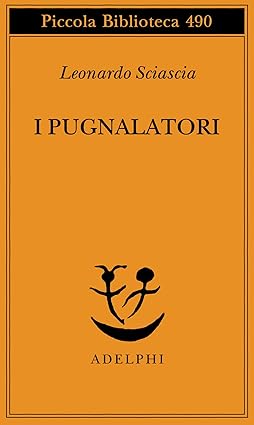
Articolo di Andrea Sartore
Palermo. Il primo Ottobre del 1862. Nella notte, alla stessa ora, vengono pugnalate tredici persone in tredici punti differenti della città. A indagare sulla misteriosa scia di sangue c’è Guido Giacosa, procuratore della città appena trasferito dal Piemonte.
Basterebbe forse questo, l’incipit di un avvincente giallo: gli esecutori materiali assicurati alla giustizia sulla base delle confessioni fatte da uno degli stessi, colto con il coltello insanguinato ancora in mano. Basterebbe il processo fatto in direttissima: colpevoli tutti. Nessuno escluso. Per fare del libro un intrigante poliziesco da leggere tutto d’un fiato. Ma c’è altro. Perché Giacosa nota delle stranezze, troppe, in quella “superficie verniciata” che si trova davanti agli occhi, perso fra ritrattazioni, alibi scricchiolanti, fughe di notizie e tentativi di depistaggio.
La sua indagine punta in alto, verso mandanti insospettabili, uno in particolare: il principe di Sant’Elia (con la complicità e la copertura dell’arcivescovado palermitano). L’accusa: aver cospirato contro il Regno d’Italia per il ritorno borbonico, utilizzando l’ordine pubblico come chiave di volta per dargli il colpo di grazia. L’opinione pubblica e i giornali reagiscono all’improvvida mossa del procuratore con sdegno: la fisionomia del principe, elargitore di elemosine e convinto senatore dell’appena nato Regno, non può essere conforme alla trama di restaurazione neo-borbonica istituita attraverso i tredici accoltellamenti. Peccato che il “convinto” senatore e principe di Sant’Elia fu altrettanto “convinto” borbonico, almeno fino al tramonto del regno, per poi rinascere, lindo e immacolato, in una nuova alba: quella dell’Italia unita. Ma Giacosa lo sa: con quello che si trova in mano un accusa non regge, non può reggere contro il principe benedetto.
Non troppo velatamente, con l’acume dell’intellettuale più che dello scrittore, Sciascia rispolvera una storia antica, accaduta realmente nella Sicilia di fine ottocento, per parlare al suo presente, quegli anni ’70 così carichi di eventi. La congiura, per assonanza di attori e di intenzioni, si trasforma allora nel ritratto lucido e divinatorio della strategia della tensione nata in Italia all’alba di un nuovo mondo. In questo caso non il Regno d’Italia, ma l’Italia all’indomani di Yalta, sulle ceneri della fine della seconda guerra mondiale.
Non più il principe di Sant’Elia, con le sue improbabili giravolte ma i fascisti, appena sconfitti nella pratica, ma amnistiati e difesi da uno Stato nuovo, deciso a mantenere le sfere d’influenza fra Est e Ovest a ogni costo, evitando lo scivolamento dell’Italia nel blocco orientale. Un intrigo troppo spesso nauseabondo e inestricabile fra apparati dello stato, intelligence straniere, manovalanza fascista/mafioso-criminale e logge massoniche più o meno coperte.
Un percorso che attua le prime prove nella strage di Portella della Ginestra (1946), per poi arrivare a compimento con: Piazza Fontana (1969), Piazza della Loggia (1974), l’Italicus (1975) e Bologna (1980). In due fasi differente e antitetiche, come pronosticato da Giacosa nel libro, come osservato da Pasolini negli stessi anni sulle pagine del Corriere, in quel potentissimo “Io so” che ha fatto storia. E chissà non ce ne sia stata una terza, a salutare la fine della Prima Repubblica e a benedire l’inizio della Seconda, con attori e intenzioni diverse, ma modalità dannatamente simili.
In un Italia vessata e disorientata dalle inchieste di Mani Pulite, abbiamo assistito alla trasformazione della mafia in un organizzazione capace di mettere in ginocchio il paese, uscendo dalle sue modalità classiche di azione, con un’efferatezza e un tono mai raggiunto prima. Che quella fase: le bombe di Capaci e via d’Amelio, le bombe del’93 a Milano, Firenze, Roma, abbiano nelle loro intenzioni, nella loro materializzazione, nella loro sofisticata trama di destabilizzazione, un aiuto esterno, lo dimostra il fatto che ci sfuggono ancora i mandanti, a trent’anni da quelle stragi.
Rimarremo probabilmente con lo stesso rammarico del Giacosa, che è quello di Sciascia e di parte dell’Italia che: “credeva di dovere la sua sconfitta, la sconfitta della legge, la sconfitta della giustizia, alla Sicilia: alle “abitudini, le tradizioni, l’indole, lo spirito di questo disgraziato paese, assai più ammalato di quanto si presuma”. La doveva invece all’Italia”.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.